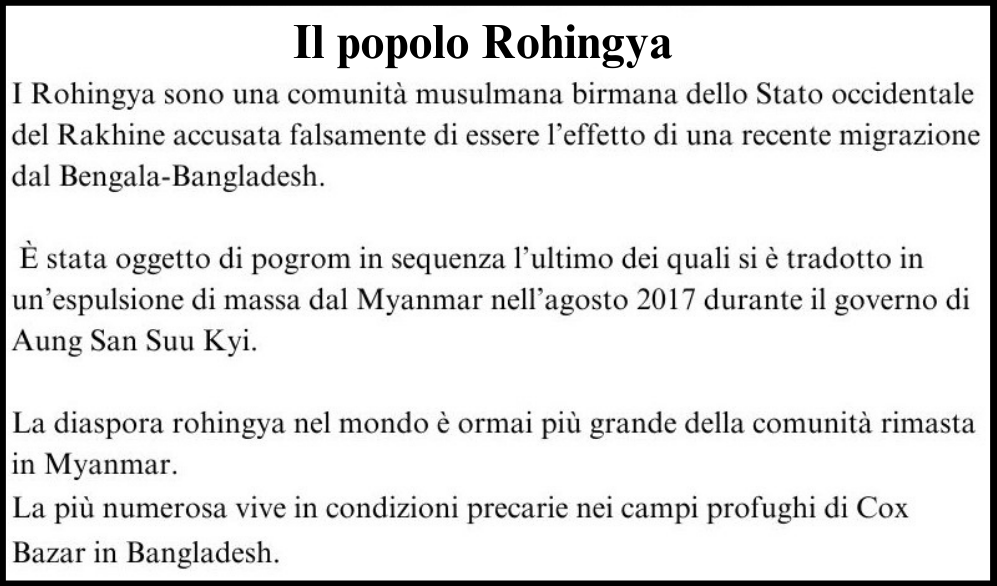Viaggio nel dramma birmano
Il soldato al check point ha l’aria distratta assai più del suo collega poliziotto che, prima di lui, ha controllato minuziosamente i documenti di tutti i passeggeri del pulmino. Il militare si accontenta della piccola mancia che l’autista gli ha accartocciato sotto le carte di identità. Mette via e fa segno di alzare la sbarra che chiude la strada. È una scena comune nel Myanmar governato da oltre due anni da una giunta militare – saranno tre il prossimo 1° febbraio – dopo che Tatmadaw, come viene detto l’esercito di quella che un tempo chiamavamo Birmania, ha preso il potere. Ma oggi, proprio i soldati su cui l’esercito faceva conto all’epoca del golpe che ha chiuso il breve periodo democratico incarnato dalla Nobel Aung San Suu Kyi, attraversano una crisi di identità e sconforto senza precedenti. Dopo 36 mesi di pugno di ferro, per la prima volta, Tatmadaw è in difficoltà. La guerra dichiaratagli dalla Resistenza, un insieme disomogeneo di organizzazioni armate, è arrivata a un punto di svolta nell’ottobre scorso quando diversi gruppi armati alleati hanno sferrato un attacco nel Nord del Paese e sigillato alcune delle città sul confine con la Cina da cui passa il grosso del commercio tra Repubblica popolare e Myanmar. La batosta militare e commerciale, ma anche l’andamento di una guerra civile che Tatmadaw non riesce a vincere, si sta sommando a un numero sempre maggiore di diserzioni e a una caccia al reclutamento – una volta ambito dai giovani birmani – che cerca di arruolare e blandire chi invece, se non si è unito alla Resistenza, sogna solo la fuga dal conflitto.
Lungo la strada che da Mandalay va verso Naypyidaw (la nuova capitale) e Yangon, gli effetti dell’offensiva di ottobre chiamata “Operazione 1027” sono evidenti. A Nord di Naypidaw, la strada di grande traffico che percorre verticalmente il Myanmar e porta a Yangon, è infatti semi deserta. Non solo perché il commercio con la Cina è bloccato ma anche perché la benzina è aumentata ed è spesso razionata. Senza contare la possibilità di incidenti sempre più in crescita – sparatorie, attentati ai mezzi militari – che sconsigliano di viaggiare se non per forza. Le code ai benzinai sono lunghe e molto spesso le pompe sono sigillate. I check point invece sono in aumento, controllati da una truppa in mimetica con le armi a tracolla che, paradossalmente, si vede solo lungo la dorsale d’asfalto se non resta sigillata nelle caserme. Nelle strade delle città o nelle campagne non si vede una divisa. “Vanno in giro in abiti civili a spiare la popolazione – ci spiega una ragazza – non si vedono ma sono dappertutto”. Hanno forse anche paura di essere troppo riconoscibili in mimetica, col rischio che un cecchino li prenda come bersaglio. Se un tempo fare il militare era un orgoglio e un lavoro pieno di benefici (casa, stipendio, status sociale), oggi i “verdi” sono guardati con sospetto o con odio. La Resistenza fa affidamento anche su questo cambiamento radicale della percezione.
“Abbiamo assistito alla diserzione e alla resa di massa dei soldati del Consiglio militare (la giunta ndr) senza precedenti nella storia militare… Osservando tutto ciò, si può dire che la fine del Consiglio militare è vicina”. Ne è convinto Duwa Lashi La, Presidente a interim del clandestino Governo di Unità Nazionale (Nug). Lo ha detto durante il suo discorso di Capodanno: “Le truppe della giunta si trovano ad affrontare quotidianamente situazioni in cui i suoi soldati si arrendono o vengono catturati in battaglia” e, a suo dire, almeno 550 soldati di Tatmadaw si sarebbero arresi solo durante l’Operazione 1027. Il Nug è il governo ombra che si è formato dopo il golpe militare. Teoricamente, Presidente e Ministro degli Esteri sono ancora Win Myint e Aung San Suu Kyi, ma i due responsabili politici della Lega per la democrazia, ora in carcere con accuse e sentenze pesantissime, sono stati sostituiti da un esecutivo a interim formatosi sulla base delle elezioni del novembre 2020 che avevano confermato il primato della Lega sul partito legato ai militari che proprio per questo hanno messo in opera un colpo di Stato minuziosamente preparato. Lo si è capito bene quando, dal 1° febbraio 2021, hanno rapidamente occupato le città con soldati e carri armati e represso nel sangue il movimento pacifico che inizialmente aveva tentato di opporsi al golpe solo con manifestazioni pacifiche di piazza e scioperi. Nel giro di qualche mese le cose sono precipitate e il movimento pacifico di disobbedienza civile si è trasformato in lotta armata. Su due direttrici: una che si appoggia sulle People’s Defence Forces (Pdf), che rispondono direttamente al Nug e sono fiorite nelle aree a predominanza Bamar (la comunità etnica maggioritaria). L’altra invece poggia sulle cosiddette Ethnic Armed Organization (EAO), ossia gli eserciti che rispondono alle diverse comunità che vivono soprattutto nelle aree periferiche del Paese. Quando nel 1948 la Birmania si affrancò dal gioco coloniale britannico, la nuova Unione nata sotto gli auspici di Aung San – padre di Aung San Su Kyi – ebbe subito problemi con le minoranze “periferiche” che da allora entrarono in un rapporto difficile e spesso conflittuale col governo centrale di Yangon (allora capitale); nel tempo, favorite anche da interessi esterni, si sono formate diverse organizzazioni separatiste o autonomiste armate. Decine di sigle, a volte di breve durata o scisse da correnti che sceglievano di patteggiare coi vari regimi militari.
Aung San Suu Kyi, ma anche i governi militari prima di lei, aveva tentato di sanare i rapporti tra comunità riprendendo in mano con maggior convinzione un processo di pace che, alla vigilia del golpe, prometteva – almeno con alcuni gruppi armati – un possibile futuro federale che avrebbe dovuto pacificare i rapporti tra la maggioranza Bamar e le formazioni autonomiste Karen, Karenni, Kachin, Chin, Mon, Arakanesi e Shan per citare le maggiori. Inutile dire che la distruzione da parte dei golpisti della giovane e fragile democrazia birmana – già messa a dura prova dal dossier Rohingya – ha fatto naufragare anche il difficile processo negoziale tra centro e periferia.
Arriviamo indenni a un villaggio importante dell’area ancora sotto controllo della giunta. Un controllo debole, come lo ha definito, già nel settembre del 2022, lo Special Advisory Council for Myanmar (SAC-M), un gruppo internazionale di ricerca. Secondo i ricercatori, delle 330 municipalità bimane (township) “in solo 72 (22%) la giunta gode di un controllo stabile” il che non significa – aggiungono – che la giunta goda di “un’influenza efficace sulla popolazione, ma semplicemente che le sue forze di sicurezza e le infrastrutture di base non hanno bisogno di essere attivamente difese”. È un’area che “costituisce solo il 17% della superficie del Paese” mentre “127 municipalità (il 39% del totale) sono contese”. E ancora: “Il controllo della giunta è contestato nel 94% di tutte le municipalità di confine”. Quelle in gran parte controllate dalle EAO.
La verità sul consenso alla giunta la si misura facilmente parlando con i locali. Non c’è bisogno di fare domande. La gente si sfoga. E c’è anche un segno evidente a chiunque di diffuso boicottaggio. La birra Myanmar, la più diffusa nel Paese e prodotta da un consorzio nippo-birmano controllato da Tatmadaw, non si trova più sugli scaffali dei negozi o nei ristoranti. Dopo il golpe, la gente ha smesso di bere un prodotto che è sempre stato chiamato “due pallottole”: l’equivalente, nel gergo popolare, del valore dell’incasso per ogni singola bottiglia. Del resto tutta l’economia è in sofferenza. La divisa locale, che ufficialmente si scambia a 2.400 kyatt per euro, ha un valore al mercato nero di quasi 3.700. Ma la giunta ha così necessità di valuta pregiata che nei negozi e persino negli aeroporti i cambiavalute la scambiano a 3.400. Un mercato nero alla luce del sole.
I numeri purtroppo raccontano anche altro. Secondo il Centro studi Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) una stima del numero di vittime del conflitto si aggirerebbe attorno a un bilancio di almeno 30mila morti, un numero ben diverso da quello fornito dall’Assistance Association for Political Prisoners (Aapp) secondo cui, nel gennaio 2024, il bilancio delle vittime civili è di oltre 4.300 decessi accertati, ossia morti certificate (con nome, luogo, data di morte). Un numero sicuramente per difetto visto che non tiene conto dei morti tra i militari, dei dispersi e dei cadaveri non identificabili oggetto dei bombardamenti dall’aria che dal 2023 Tatmadaw utilizza sempre più spesso quando non è in grado di avanzare sul terreno. Anche il numero degli sfollati interni è enorme: oltre due milioni e mezzo, secondo l’Unhcr, di cui diverse centinaia di migliaia dovuti alla sola Operazione 1027.
I numeri sulle formazioni combattenti sono invece difficili da accertare. Le milizie etniche possono contare su diverse formazioni con peso militare diverso mentre le Pdf sono per il momento gruppi di guerriglia tradizionale (urbana e non) cui parte delle EAO (una decina sono alleate col Nug) forniscono training militare. Oltre centomila combattenti anti giunta potrebbe essere una stima attendibile. Tatmadaw è ovviamente più forte sul fronte operativo dell’hardware bellico (terra, mare e aria) con armamento leggero e pesante e soprattutto aviazione. Può contare su un numero di effettivi e combattenti maggiore, eroso però dall’alto numero di rese e diserzioni. Secondo Andrew Selth, autore di Burma’s Armed Force e di Secrets and Power in Myanmar, all’inizio del 2021 Tatmadaw era formato da un numero stimato tra 300.000 e 350.000 effettivi, che ora sarebbe sceso a 200-250.000. Gli operativi – ossia i combattenti – sarebbero circa 100mila, cui vanno aggiunti altri 80mila uomini della polizia nazionale. Ma il futuro incerto sul confronto militare non è l’unico problema cui si trova di fronte la Resistenza birmana. Il cui primo nodo è proprio l’agenda soggettiva dei singoli gruppi. Se il Nug ha in mente un percorso che trasformi la dittatura in una forma di governo federale inclusivo, gli eserciti etnici hanno come primo obiettivo la loro autodeterminazione, negata sin dalla nascita della Birmania indipendente. Inoltre, alcuni di loro stanno con la giunta. Altri restano alla finestra.
 Questa incertezza sugli obiettivi si riflette per ora, sul piano militare, nell’incapacità di avere un solo vero comando unificato che possa dunque coordinare tutte le azioni combattenti. Una situazione a cui sembra che le diverse forze stiano cercando di porre rimedio. Ma la vera sfida è sul piano politico. Il Nug è sostenuto da un’istituzione legislativa (Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw) che rappresenta le varie comunità e sta lavorando alle linee guida di una futura federazione e a una nuova Costituzione (che tra l’altro prevede l’inclusione dei Rohingya come comunità birmana riconosciuta). Ha per esempio espresso un documento condiviso sul piano educativo che fissa le linee guida dell’insegnamento scolastico nelle aree liberate e prefigura i pilastri del sistema dell’istruzione in una futura struttura federale. Comprende per esempio lo studio del Bamar ma anche dell’idioma locale e di una lingua straniera. Parlando, nel nostro viaggio, con gli insegnanti di una delle aree periferiche liberate abbiamo visto il tentativo di raggiungere un accordo sul piano nazionale ma è difficile dire quanto venga applicato fuori dalla zona che abbiamo visitato dove era stato accolto con attenzione. La sfida più complessa per un futuro Myanmar non è tanto la guerra quanto la pace. Una vittoria della Resistenza è possibile sul medio-lungo periodo ma i veri nodi verranno dopo, figli di un rapporto difficile tra le diverse nazionalità, da anni di conflitto, e da una fiducia reciproca che resta da costruire.
Questa incertezza sugli obiettivi si riflette per ora, sul piano militare, nell’incapacità di avere un solo vero comando unificato che possa dunque coordinare tutte le azioni combattenti. Una situazione a cui sembra che le diverse forze stiano cercando di porre rimedio. Ma la vera sfida è sul piano politico. Il Nug è sostenuto da un’istituzione legislativa (Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw) che rappresenta le varie comunità e sta lavorando alle linee guida di una futura federazione e a una nuova Costituzione (che tra l’altro prevede l’inclusione dei Rohingya come comunità birmana riconosciuta). Ha per esempio espresso un documento condiviso sul piano educativo che fissa le linee guida dell’insegnamento scolastico nelle aree liberate e prefigura i pilastri del sistema dell’istruzione in una futura struttura federale. Comprende per esempio lo studio del Bamar ma anche dell’idioma locale e di una lingua straniera. Parlando, nel nostro viaggio, con gli insegnanti di una delle aree periferiche liberate abbiamo visto il tentativo di raggiungere un accordo sul piano nazionale ma è difficile dire quanto venga applicato fuori dalla zona che abbiamo visitato dove era stato accolto con attenzione. La sfida più complessa per un futuro Myanmar non è tanto la guerra quanto la pace. Una vittoria della Resistenza è possibile sul medio-lungo periodo ma i veri nodi verranno dopo, figli di un rapporto difficile tra le diverse nazionalità, da anni di conflitto, e da una fiducia reciproca che resta da costruire.
Foto Credits: Alessandro De Pascale (atlanteguerre.it) da https://www.atlanteguerre.it/dentro-il-myanmar/